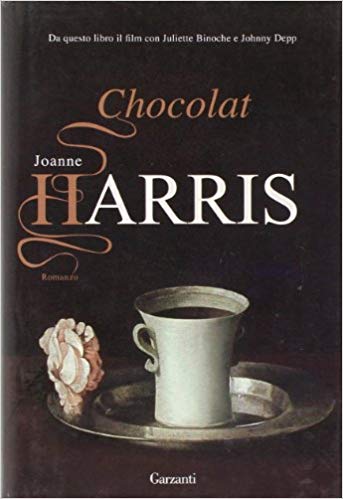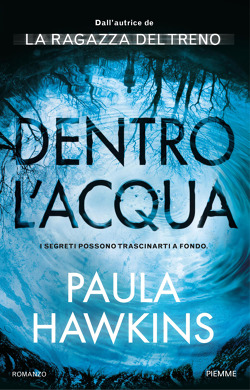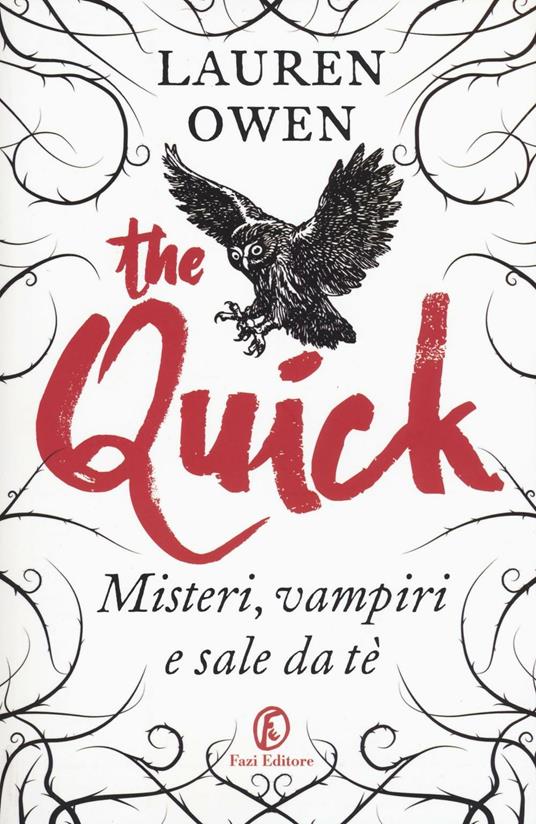Questo romanzo completa ciò che io definisco la mia personale “trilogia dell’Africa”. Tutto è cominciato quando qualche tempo fa lessi “Tra cielo e terra” di Paula McLain, sempre edito da Neri Pozza (lo trovate QUI ) , un romanzo che mi piacque molto e che mi fece incontrare per la prima volta Beryl Markham, donna straordinaria ed autentica pioniera dell’emancipazione femminile. La McLain sviluppa alcuni aspetti della vita di Beryl componendo l’ideale prolungamento dell’autobiografia romanzata della donna, che scrisse “A occidente della notte” per suggellare tra le pagine il suo legame d’amore con il continente Africano. Quando lessi “Tra cielo e Terra” mossi una critica al romanzo, l’unica: non capivo perché l’autrice insistesse così tanto sul privato di Beryl, anche se movimentato ed intrigante, trascurando invece gli aspetti più interessanti della sua vita: fu la prima donna ad ottenere il brevetto come allevatrice di cavalli (aveva solo 17 anni) e la sua passione per il volo la portò a diventare un’aviatrice di professione. Il suo spirito di avventura la spinse persino a tentare un’impresa straordinaria per l’epoca: il volo transoceanico in solitaria, da Londra a New York.
Una volta terminata anche questa lettura ho però compreso: tutto quello che desideravo sapere su questa donna così all’ avanguardia si trova in questo romanzo, scritto con le sue stesse mani, prima che i ricordi potessero essere cancellati dalla vecchiaia. E’ come se, leggendolo, ci soffermassimo a lungo ad ammirare una fotografia, incapaci di staccare gli occhi dalle immagini: la natura ancora vergine ed inospitale del Kenya, le capanne di fango dei primi coloni, i leoni distesi all’ ombra delle grandi acacie, gli elefanti che si spostano in branco seguendo i corsi d’acqua…La scrittura di Beryl è evocativa, di forte impatto, regala incredibili suggestioni ed è avara di dettagli. Tralascia volutamente tutto quello che con l’Africa non ha niente a che spartire: amori (tanti), amanti (uno su tutti, di cui parlerò più avanti) e mariti (tre) per farci immergere completamente nell’ atmosfera maliarda e sognante di un mondo ormai scomparso, che lei ha avuto il privilegio di dominare come e più di un uomo. La vita di Beryl Markham fu un turbinio di avventure, non si conformò ai dettami dell’epoca, fu spericolata nel lavoro come nella vita privata, assolutamente incapace di coltivare relazioni stabili e durature. La società coloniale dei primi del 1900 non differiva da quella vittoriana, non era altro che la sua proiezione: i pionieri si illusero di poter trasportare il loro bagaglio culturale anche in Kenya, credendo che fosse facile plasmare quella terra selvaggia e assoggettarla ai loro “giusti” ideali politici, religiosi e sociali. Beryl rimase sempre piuttosto estranea a riguardo, conservando sempre, per tutta la vita, un punto di vista molto diverso da quello che ci si aspettava da una donna occidentale. Non era una presa di posizione, per lei era normale considerare l’Africa come una madre terra da rispettare, con i suoi ritmi, i suoi cicli, la sua perfetta simbiosi con le leggi immutabili della natura. Non era facile far convivere dentro di sè questo sentimento così forte di appartenenza con le necessità di vivere comunque in mezzo alla società bianca dell’epoca, che a Nairobi aveva il suo quartier generale: a volte era necessario scendere a qualche compromesso per poter sopravvivere.
Nel suo romanzo Beryl dedica poco tempo a parlare delle persone che popolarono la sua vita, fatta eccezione per alcuni uomini: suo padre, il suo grande amico indigeno Kibi, Tom Backer (l’aviatore inglese che le insegnò ogni cosa sul volo) e il barone Blixen, il marito della celeberrima Karen. Quest’ultimo era una vera autorità a Nairobi: appassionato cacciatore, l’aveva ingaggiata più volte per aiutarlo duranti i safari che organizzava per i suoi ricchi amici, affinché sorvolasse le zone circostanti al campo base in cerca di elefanti. Il sogno dell’ uomo bianco, a quei tempi, erano le magnifiche zanne d’avorio dei mastodonti africani, che possedevano solo i maschi; ma il branco li proteggeva e, animali di straordinaria memoria ed intelligenza quali sono, imparavano a nascondersi in territori impervi, visibili solo dall’ alto. Beryl doveva avvistarli e segnalarli ai cacciatori, scrivendo le coordinate su fogli di carta che poi lanciava a terra dentro scatole di latta. Ancora una volta Aveva trovato un modo straordinario per guadagnarsi da vivere.
L’idea di utilizzare l’aereo per i safari non fu però del barone Blixen, nè di Beryl Markham. Fu di Denis Finch – Atton, affascinante avventuriero, cacciatore e pioniere che si lasciò sedurre dall’Africa non meno che dalle donne. Denis era l’amante della baronessa Blixen, ma le cronache mondane dell’epoca vogliono Beryl perdutamente innamorata di lui. Lui che, invece, restò sfuggente e fedele solo a se stesso, e morì libero, così come aveva sempre vissuto. Beryl lo conobbe in aeroporto a Nairobi, perché Finch-Atton era anche un appassionato aviatore, esattamente come lei. Erano spiriti affini, e questo Beryl ce lo fa intuire attraverso rare parole.
La baronessa Blixen, come è ovvio che sia, non fu mai una sua grande amica: l’una sapeva dell’altra, e viceversa. Erano donne profondamente diverse, e sebbene entrambe abbiano tributato un grande omaggio al continente africano, la natura del loro innamoramento non fu mai la stessa. La Blixen arrivò in Africa in età adulta, in cerca di avventure come tutti i coloni dell’epoca, annoiati dalla loro nobiltà; ma poi il Kenya intrappolò il suo cuore in una presa mortale, che la segnò profondamente. Amò con tutta sè stessa quella natura selvaggia baciata da un clima straordinariamente mite, l’immensa distesa di colline verdi che circondava Nairobi, i cieli senza crepuscolo, ogni cosa: ma nulla di tutto questo le appartenne mai veramente. Fu solo un’amante, una donna bianca che sapeva capire, amare e rispettare i riti antichi che governavano quel mondo; rimase però sempre un’estranea, con il dubbio che l’Africa le restituisse poco di quell’ amore che lei invece le aveva donato incondizionatamente.
Beryl invece fu sempre parte integrante di quel mondo ancestrale. I suoi ricordi d’infanzia si perdono tra le quattro assi di una capanna di legno e fango tirata su nel cuore del nulla, intorno alla quale suo padre si faceva largo con il machete, per dare forma al suo sogno. Una fattoria, i cavalli, una piantagione di caffè. La mamma non compare mai nei suoi ricordi, perché l’abbandonò subito dopo il suo arrivo: lei non era fatta per quell’ avventura al confine del mondo. Ciò che la Blixen apprende con gli anni, per Beryl fu una cosa del tutto naturale: parlava le lingue degli indigeni, giocava con loro, partecipava alle loro battute di caccia, alle loro feste. Così Beryl cresce, libera e selvaggia, imparando a cavalcare e a cacciare come un Kikuyo, fiera e rispettata sia dagli uomini del suo tempo che dagli stessi indigeni che l’avevano accolta. Non conosce altre radici che quelle africane, ed a queste decide di rimanere ancorata anche quando il sogno di suo padre va in frantumi: rimarrà in Africa, ad allevare cavalli, da sola. Si guadagnerà da vivere così, anche se ha appena 17 anni. Non so se sia stato il coraggio o la disperazione a guidare le scelte di Beryl, l’unica cosa certa è che questa sua intraprendenza le derivava da un amore viscerale per quella terra che l’aveva nutrita, prima che nel corpo, nell’ anima.
“I contendenti della conquista hanno trascurato l’anima vitale dell’Africa stessa, da cui emana la resistenza autentica alla conquista… l’Africa appartiene ad un’era antica e il sangue di molte delle sue genti è altrettanto venerabile e puro… quale razza di nuovi arrivati, spuntata da un secolo recente… può eguagliare in purezza il sangue di un singolo masai murani, il cui retaggio forse affonda le sue radici poco lontano dall’Eden?”
Questo suo spirito indomito e battagliero la fece considerare dai posteri come una specie di femminista “ante litteram”: credo che questa definizione abbia fatto sorridere parecchio Beryl, quando alle soglie della vecchiaia ripercorse la sua vita per dare forma al romanzo. Perché in realtà Beryl non dovette mai combattere contro niente e contro nessuno: la sua presenza all’ interno della società coloniale, fatta prevalentemente da uomini, era accettata di buon grado come fosse una cosa naturale, inevitabile. Ricopriva dei ruoli che nessuno le contestò mai: allevatrice di cavalli, aviatrice. Il suo status fu sempre largamente accettato, condiviso e rispettato anche quando prese delle pieghe non proprio edificanti. La Blixen invece non riuscì mai ad elevarsi al di sopra dei pregiudizi che l’epoca vittoriana portò con sè anche al di là dell’Oceano: rimase sempre prigioniera del vecchio retaggio culturale di cui era figlia.
La diversità di queste donne ci ha regalato due libri stupendi, che non dobbiamo mettere in contrapposizione l’uno con l’altro: sarebbe un errore, perché sono perfettamente complementari. Quello che manca in uno, lo troviamo nell’ altro. Lo stile navigato della Blixen, che fece della scrittura la sua professione, non è paragonabile a quello appassionato e acerbo della Markham. Se si può fare una critica a questo romanzo, sta proprio nello stile spesso elaborato e nella ricerca continua del lirismo, anche quando la circostanza non lo richiede. A volte ho fatto fatica a seguire i suoi voli pindarici: quando si perde nelle descrizioni struggenti dei paesaggi africani la scrittura diventa un fiume impetuoso di immagini e nomi, come quando si apre dopo tanto tempo la scatola dei ricordi. Ogni oggetto ha la sua storia, e tessere un filo temporale che tenga tutto in ordine cronologico è complicato ed inutile. Così mi sono lasciata trasportare dall’ onda della memoria che riaffiora, senza pormi troppe domande, godendo delle emozioni che la scrittura porta a galla.
E’ sbagliato definire il romanzo un’autobiografia, perché la cronistoria dei fatti, la descrizione dei personaggi e la loro collocazione nella storia sono di secondaria importanza rispetto al corpo della narrazione, che è basata su tutt’ altro. Viene rivelato solo lo stretto necessario a comprendere ciò che l’Africa ha rappresentato per questa donna: l’amore assoluto, il senso di appartenenza, il significato di una vita intera.
A occidente con la notte – Beryl Markham (Neri Pozza)