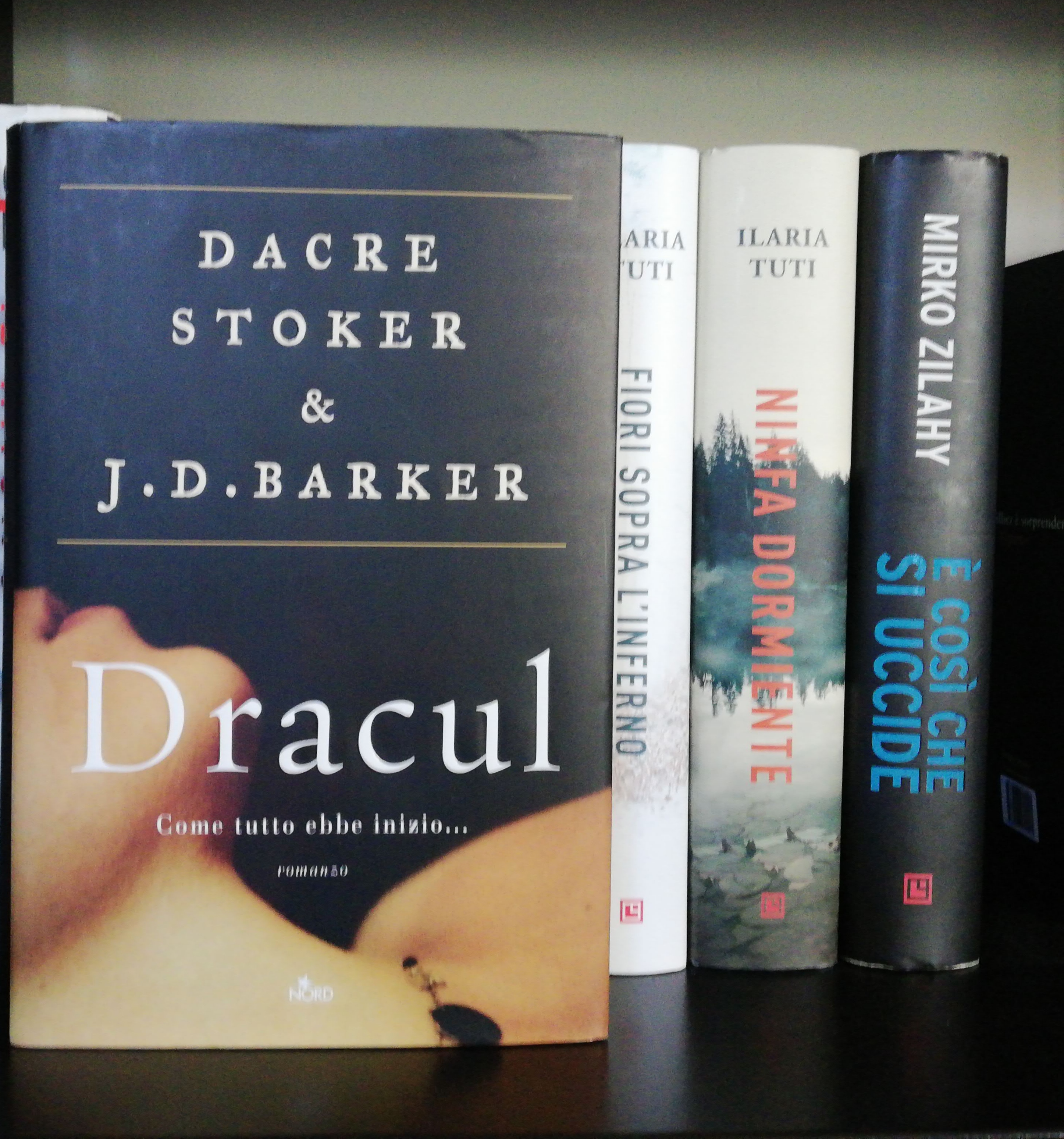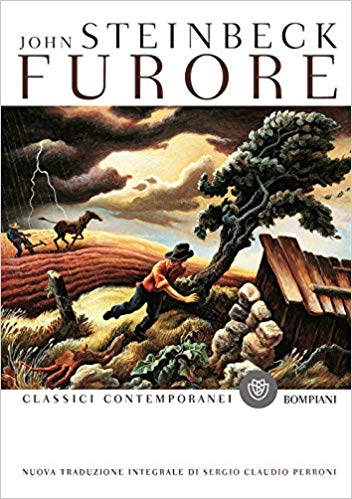IL PARTIGIANO JOHNNY, di Beppe Fenoglio

“Il partigiano Johnny” è un romanzo autobiografico di Beppe Fenoglio rimasto incompiuto e pubblicato postumo nel 1968, ideale prosecuzione del precedente “Primavera di bellezza”. Johnny, soprannominato così a causa della sua passione per la letteratura inglese, è un giovane ex ufficiale dell’esercito italiano che, in seguito all’armistizio firmato dal maresciallo Badoglio l’ 8 settembre 1943, approfittando del caos che tale decisione provocò all’interno delle forze armate, decide di disertare e di fare ritorno al paese natìo, dove per qualche tempo conduce una vita da imboscato sulle colline di Alba, nascosto dalla famiglia. Poco dopo però, insofferente a quella vita monotona e codarda, si arruola nel primo gruppo di partigiani che incontra in zona, di estrazione comunista, pur non approvandone né l’ideologia né la disorganizzazione con la quale affrontano la guerriglia. Proprio a causa di alcuni terribili errori di strategia il suo gruppo fu portato al massacro; Johnny, tra i pochi superstiti dell’ eccidio, cambierà definitivamente fazione passando ai partigiani badogliani, più moderati e più in linea con le sue idee militari. Potrebbe sembrare uno dei tanti romanzi antifascisti che omaggiano la storia della resistenza, invece è molto più di questo: fin dalla prime pagine intuiamo che la storia di Johnny ha un respiro differente, più profondo ed esistenziale. La grandiosità di questo romanzo sta infatti nella visione anti eroica con cui Fenoglio racconta la resistenza italiana, ponendo invece l’attenzione sul dramma umano, sulla crudeltà della guerra civile e sulla sua insensatezza. Ciò che lo distingue dalla letteratura di genere e che lo inserisce di diritto tra i più importanti romanzi del novecento è la profonda dimensione esistenziale che si astrae dal contesto e che rende universale le vicende umane di Johnny. La lettura di questo romanzo è, inoltre, un’ esperienza linguistica affascinante: la scrittura è pregna di invenzioni lessicali, inglesismi mescolati a retaggi dialettali e spesso i pensieri di Johnny vengono espressi con termini inglesi arbitrari ed adattati alla prosa. Un’ autentica avventura che all’inizio può sembrare un po’ ostica ma, se riusciamo ad accoglierla e abbandonarci ai suoi manierismi, ci appagherà in maniera totalizzante.
L’ AGNESE VA A MORIRE, di Renata Viganò

“L’ Agnese va a morire” è un romanzo dal titolo emblematico, che ci svela fin da subito quale sarà il tragico epilogo della storia raccontata da Renata Viganò. Agnese è una lavandaia di mezza età che vive nelle valli di Comacchio con il marito Palita, un uomo molto debole di costituzione che, impossibilitato a svolgere lavori di fatica, si dedica anima e corpo alla politica. A causa delle sue posizioni antifasciste Palita viene catturato e ucciso dai tedeschi, lasciando Agnese in balìa della disperazione e di un odio feroce che comincia a montarle dentro giorno dopo giorno, fino a culminare nell’omicidio di un soldato tedesco che per divertimento uccide l’amatissima gatta del marito. In seguito a quel gesto Agnese deciderà di rifugiarsi presso un gruppo di partigiani, con i quali comincia a vivere in clandestinità. Quell’ istintiva ribellione alla brutalità dell’ occupazione nemica fa maturare in lei, donna priva di cultura e di coscienza politica, una nuova consapevolezza che la porterà a diventare un’attivista della lotta partigiana. “Mamma Agnese” , questo il suo nome di battaglia, avrà un ruolo fondamentale nella guerriglia, meno militaresco e più umano, in cui si occupava dei militanti sfamandoli e sostenendoli, svolgendo lavori di logistica e di vivandiera. Pedalando con la sua bicicletta attraverso le Valli di Comacchio traporta cibo, munizioni e informazioni sfidando la sorte ogni giorno come staffetta, sempre al fianco dei suoi ragazzi, sempre fedele al suo battaglione, fino all’ultimo estremo sacrificio. Un romanzo anch’esso autobiografico, una testimonianza quasi in presa diretta degli accadimenti di quegli anni che non vengono mai edulcorati, ma raccontati con crudele realismo e struggente bellezza. E non è vero, come si legge nella chiosa, che di lei “resterà solo un mucchio di stracci nella neve sporca“: Mamma Agnese sarà per sempre un simbolo di forza, di fede, di speranza, di coraggio, il sacrificio di chi lotta senza remore, senza imposizioni e senza ideali altisonanti, ma solo perché è giusto.
IL CORAGGIO DI CION, di Daniele La Corte

“Il coraggio di Cion” racconta la storia vera del partigiano Silvio Bonfante, nome di battaglia Cìon, che in dialetto del ponente ligure significa “chiodo”. Nato ad Oneglia (oggi Imperia) nel 1921, durante gli anni della resistenza come molti altri suoi coetanei si arruola nelle truppe partigiane dell’entroterra ponentino. Grazie alle sue doti di stratega diventa prima comandante di una banda, poi vice comandante della divisione “volante“, preposta alle più rischiose operazioni d’ assalto. La breve vita di Cion è una storia autentica che l’autore ha cercato di rendere ancora più vera ponendo l’accento sull’uomo nella sua complessità oltre che sul guerrigliero, un ragazzo di soli 23 anni con i suoi sogni, le sue paure e debolezze, i suoi affetti. Trascorre la sua esperienza da partigiano senza mai dimenticarsi della famiglia, soprattutto della sorella Anna, a cui è profondamente legato e che cerca di proteggere in ogni modo. Anche quando la lotta si farà dura e disperatamente incerta, su quelle montagne scenari di terribili e feroci scontri, la vita continua a pulsargli nelle vene e pretende di essere ascoltata: arriva l’amore e ha gli occhi di Fiammetta, una giovane staffetta che riuscirà a mettere a nudo la tenerezza di quel comandante così duro e deciso, svelandone l’aspetto più intimo e riservato. La battaglia di Monte Grande, tragicamente famosa per l’eroismo dimostrato da quel manipolo di partigiani che riuscì a mettere in fuga le truppe tedesche ben più numerose e meglio organizzate, trasforma Cion in un eroe leggendario. Un’impresa epica, ardita e quasi folle, che ancora oggi viene festeggiata ogni anno, la domenica più prossima a quell’indimenticabile 5 settembre 1944.
Come ogni eroe che si rispetti, anche Cion morirà sul campo di battaglia, a Briga Alta (CN), il 17 ottobre 1944. Un ultimo atto di coraggio e di sacrificio estremo che gli valse, nel 1946, la Medaglia d’oro al valore, con questa motivazione: “In nove mesi di continua lotta contro i nazifascisti creava intorno a sé, con le sue epiche gesta, un’aureola di eroica leggenda. Trascinatore entusiasta e combattente valorosissimo, ebbe largo seguito di giovani che, animati dal suo valore, accorrevano ad impugnare le armi per la redenzione della Patria. Ferito durante un cruento combattimento e raccolto in un ospedale da campo che veniva circondato da SS. tedesche, visto cadere al suo fianco il medico che lo curava e preclusa ogni via di scampo, per non fare trucidare i porta feriti e non cadere vivo nelle mani del nemico, si uccideva, concludendo la sua vita col volontario supremo sacrificio. Fulgido esempio di valore e di sublime altruismo”.