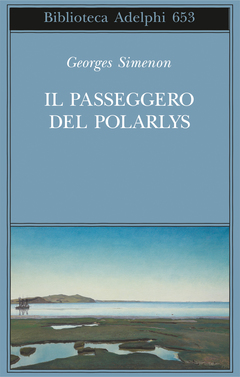La forza dei romanzi dedicati al Commissario Maigret risiede in due punti fondamentali: l’ambientazione, sempre particolarmente suggestiva, e lo spessore psicologico dei protagonisti. La trama e l’intreccio giallistico passano in secondo piano, perchè l’attenzione si sposta sempre verso l’aspetto umano più che su quello metodologico delle indagini. Simenon è stato l’autore che, negli anni trenta, ha rivoluzionato il genere del romanzo poliziesco: lo schema del giallo classico, tutto improntato sulla ricerca meticolosa del colpevole e sull’analisi minuziosa della scena del crimine, viene abbandonato in favore di ambientazioni popolari e piccolo borhgesi, microcosmi proletari in cui sono gli esseri umani con i loro turbamenti ad essere scandagliati ed osservati, per arrivare infine a comprendre le motivazioni del delitto più che il movente in sè. Anche questa volta ritroviamo gli stessi elementi, amalgamati però in modo differente dal solito: il vero protagonista diventa il paesaggio isolano, che cattura i suoi avventori in un vortice di emozioni a cui nemmeno Maigret può sottrarsi. L’intreccio psicologico quasi non esiste, la trama è lineare e semplice, al punto che spesso durante la lettura non ci accorgiamo nemmeno che il commissario stia in realtà svolgendo un’indagine per omicidio: i colloqui sono scarni, rari, gli interrogatori rapidi e sembrano non portare a nulla, ancora più del solito. I personaggi che incontriamo, seppur variegati, li abbiamo tutti più o meno già incontrati nella galleria umana di Simenon, ma questa volta anzichè sfuggire tra dimenticati bistrot della periferia parigina o lungo le strade della campagna francese sono tutti prigionieri della malìa dell’isola, che avvinghia e fa ammalare di “porquerollite”, come affermano gli abitanti stessi.
Maigret viene chiamato nel cuore del mediterraneo perché è stato assassinato un uomo, tale Marcelline, un malvivente da quattro soldi che la sera prima del delitto aveva dichiarato di essere amico del famoso commissario parigino. Maigret è ormai diventato un personaggio di spicco, uno che compare sui giornali nazionali e che fa molto parlare di sè per la brillante risoluzione di casi difficili. Addirittura la sua notorietà ha attraversato La Manica, destando curiosità persino tra i colleghi di Scotland Yard, che proprio nei giorni dell’assassinio decidono di spedire in visita al Quai des Orfèvres il pari- grado commissario Pyke. Pyke viene accolto con sollecitudine dai colleghi francesi e messo alle costole di Maigret, affinché possa vedere con i suoi occhi in cosa consiste il suo tanto decantato metodo, che poi metodo non è.
Una volta approdato sull’isola Maigret si lascia completamente trasportare, vittima inconsapevole di quella strana malattia che gli abitanti del posto conoscono così bene. Il porticciolo con le sue imbarcazioni turistiche, le barche tirate in secca dai pescatori che quando c’è il Mistral stanno tutto il giorno a cucire le reti, la piazzetta su cui si affaccia l’unico ritrovo del posto, “L’Arche de Noe”: con poche sapienti pennellate Simenon descrive un paesaggio che sembra sbucato fuori da un quadro impressionista, regalando al lettore intense suggestioni. Il Mistral se n’è andato lo stesso giorno in cui Maigret è sbarcato in quel luogo incantato, in cui il tempo sembra avere un respiro differente rispetto a quello che scorre a Parigi. Il tempo qui si dilata fino a farti dimenticare di vestirti per uscire dalla tua stanza d’albergo, ritrovandoti in ciabatte e veste da camera ad osservare il via vai del porto. E poi l’odore della domenica, un profumo di caffè e nostalgia che Maigret riconoscerebbe ovunque e che qui sull’isola è così amplificato da sconfiggerlo inesorabilmente, un sentimento languido a cui vorrebbe potersi abbandonare. Eppure, tra quelle viuzze bianche investite da colori e profumi mediterranei, è stato commesso un efferato omicidio. Ed il colpevole non se ne è mai andao. Si aggira noncurante insieme agli altri abitanti dell’isola, trascorrendo oziose giornate al sole caldo della primavera provenzale, tra un bianchino consumato all’Arche de Noè ed una partita a petanque. Tocca quindi investigare, e quel che è peggio è che lo deve fare in presenza di Pyke, il quale forse si aspettava qualcosa di più da quel viaggio e invece gli tocca fare il turista. Perchè quando Maigret si mette all’opera non prende penna e taccuino e non scandaglia la scena del crimine come un radar, ma comincia ad osservare: scruta la varietà umana che per un motivo o per l’altro popola l’isola – ognuno con un buon motivo per restare ed altrettanti per andarsene – si immerge nelle atmosfere che lo circondano e si lascia guidare dalle sensazioni che gli arrivano fino a quando, finalmente, tutto gli sarà chiaro. Come si può spiegare all’inglese Pyke cosa è l’intuizione, e come arriva? ” Questo è il mio metodo”, gli spiega Maigret. E noi, una volta di più, abbiamo la certezza che nulla come l’empatia verso i nostri simili sia la chiave per comprendere la complessità delle vicende umane.