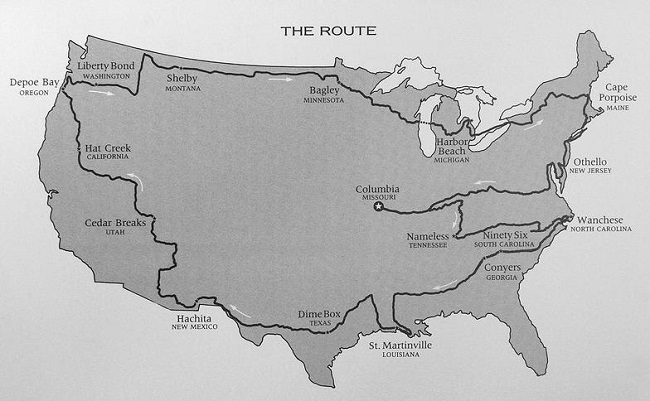Oggi Triora è un borgo medievale molto caratteristico, dal fascino indiscutibile. Arroccato su una collina, come la maggior parte dei paesi dell’entroterra ligure, è un susseguirsi di stradine acciottolate che si perdono tra le costruzioni medievali, si avvitano su se stesse per ricongiungersi infine alla piazza principale del paese: un crocevia antico sospeso tra realtà e leggenda. Ci sono stata molte volte, affascinata da questi luoghi così ricchi di storia. Una storia purtroppo macchiata di sangue, che ha visto il paese protagonista di uno dei più terribili e crudeli episodi della vicenda tristemente nota come “caccia alle streghe”. La profonda ignoranza in cui l’umanità intera era sprofondata nei secoli bui del medioevo aveva piantato radici talmente profonde che la paura si era tramutata in immotivata ferocia nei confronti di chi, con la propria personalità o peggio ancora con il proprio mestiere, appariva diverso dalla gente comune. Le levatrici ad esempio, che sapevano utilizzare molto bene le erbe curative, ero guardate con sospetto.
Le donne diventarono il primo bersaglio contro cui si scagliò l’ ignoranza delle masse: avere i capelli rossi, splendido dono di madre natura, bastava per essere considerate concubine del maligno. La sensualità, la procacità, la bellezza esuberante destavano terrore perché capaci di stordire; un uomo che subiva la malìa di una donna era senza ombra di dubbio vittima di un maleficio, l’idea che potesse essere una semplice conseguenza dell’ attrazione sessuale non era accettabile. Il ciclo mestruale era visto come qualcosa di orribile e disgustoso di cui vergognarsi profondamente, da cui bisognava purificarsi. Coincidente con quello lunare, anch’esso di 28 giorni, portava con sé mistero e diffidenza. La capacità di dare la vita era una prerogativa che poteva mettere in discussione la predominanza del genere maschile ed inoltre, proprio in virtù di questa possibilità, le donne erano le uniche creature in grado di generare il figlio di Satana. Tutto questo generò negli uomini un terrore persecutorio, che sfociò in una serie abominevole di arresti, torture e condanne al rogo. Le donne di Triora, così dice la leggenda, si incontravano con il demonio in un posto chiamato “La Cabotina”,un piccolo quartiere con uno spiazzo che si affaccia a precipizio sulla vallata, fuori dalle mura del paese. Si narra che durante le notti di plenilunio le amanti di Satana si scatenavano in balli osceni e si accoppiavano con il loro signore dando vita ad orge sfrenate.
Oggi tutto questo sembra una storiella da quattro soldi, che non spaventa più nemmeno i bambini. Il paese stesso gioca molto sul mito delle Streghe, organizzando veglie di Halloween in tema e festival vari della stregoneria per richiamare turisti curiosi, come è normale che sia. Resta il fatto che la “caccia alle streghe” a Triora sia realmente esistita, e sia diventata famosa per l’estrema crudeltà dei fatti.
Molti storici hanno studiato le vicende di Triora, mettendo insieme i pezzi di una storia che a distanza di secoli mette ancora i brividi, ma non per la paura di qualcosa di sconosciuto che sconfina nella leggenda, come le storie di fantasmi e lupi mannari. Ma perché è stato un massacro spietato, reale, terribile. Perché erano, in fondo, solo donne.
Donne che, magari, con la loro conoscenza o la loro bellezza potevano minacciare la piccolezza di uomini codardi. Donne che sono diventate il capro espiatorio di un potere corrotto. Saranno anche passati i secoli, la pubblica gogna non esiste più, l’Inquisizione e le torture sono solo un brutto capitolo della storia dell’uomo… ma possiamo affermare con serenità che oggi noi donne non ne paghiamo più lo scotto? L’intelligenza, la cultura, l’indipendenza economica e la bellezza di un donna purtroppo sono ancora in grado di scatenare la furia omicida. Basta guardare ogni giorno il telegiornale per rendersi conto che facciamo ancora tanta, troppa paura. Una paura che genera follia negli animi più miserabili. Ma questa è un’altra storia. Questa invece è la storia delle streghe di Triora, che stasera danzeranno alla Cabotina facendosi beffe degli uomini che hanno creduto di sconfiggerle, perché non ci sono mai riusciti davvero. E la pioggia non disturberà la loro festa notturna.

Curiosità e misteri
Il nome Triora deriverebbe dal latino “tria ora”, cioè “tre bocche”, esattamente come le tre bocche di cerbero, il cane infernale posto a guardia degli inferi e raffigurato sullo stemma comunale di Triora.
Secondo la tradizione la chiesa della Collegiata sorgerebbe su un precedente “fanum” pagano.
Nei pressi di Triora, al passo della Mezzaluna, si erge un antichissimo “menhir”, testimonianza di precedenti culti pagani.
Nella chiesa romanica di S. Bernardino è visibile un affresco di Giovanni Canavesio raffigurante un Giudizio Universale con tanto di streghe ed eretici fatti a pezzi e bambini, morti senza ricevere il battesimo, posti sotto le gigantesche ali da pipistrello di un demone.
“Sul finire dell’estate del 1587 a Triora, millenario borgo di montagna del Ponente ligure, tirava una brutta aria; da circa due anni la gente non aveva più di che sfamarsi e nel giro di pochi giorni alcune donne che abitavano alla periferia del paese furono ritenute responsabili di questa presunta carestia. L’accusa? Essere streghe, o meglio bagiué, secondo il dialetto locale. Queste sono le premesse con le quali ha inizio uno dei più feroci processi alle streghe in Italia, per nulla inferiore in quanto a drammaticità a quelli di Loudun e di Salem, rispettivamente in Francia e in America. All’epoca dei fatti, Triora era un borgo fortificato al centro di intensi traffici commerciali tra il Piemonte, la costa e la vicinissima Francia. Politicamente dipendeva da Genova, di cui era podesteria, difesa da ben cinque fortezze al cui interno era di stanza una guarnigione di soldati della Repubblica.
Nell’ottobre del 1587 il Parlamento locale, composto per lo più da persone rozze e ignoranti, con il beneplacito del Consiglio degli Anziani e del Podestà, stanziò cinquecento scudi per imbastire un processo; una cifra enorme in relazione alla condizione economica del borgo stesso. L’autorità ecclesiastica non tardò a intervenire; giunsero infatti il vicario dell’Inquisitore di Genova e il vicario dell’Inquisitore di Albenga, Gerolamo Del Pozzo. La prassi del tempo consisteva nel celebrare messa nella chiesa parrocchiale, invitando il popolo alla delazione.
Il processo di Triora non stupisce inizialmente per il suo corso che ricalca nella sostanza molti altri con tutte le ripercussioni del caso. Si confiscarono alcune abitazioni private da adibire a prigione e non tardarono ad arrivare le prime vittime della giustizia: tra le prime venti donne incarcerate morirono la sessantenne Isotta Stella e un’altra donna, quest’ultima nel tentativo di calarsi da una delle finestre del carcere. Di streghe morte la storia ne è piena, ma ciò che lascia perplessi è l’evolversi della situazione.
Il Consiglio degli Anziani, essenzialmente composto dai proprietari terrieri, mostrò le sue perplessità verso il processo quando le prime “matrone” di Triora furono incarcerate. La delazione, gli odi e le invidie personali stavano dilagando a tal punto da mettere sullo stesso piano, di fronte alla macchina della giustizia, le nobildonne come le prostitute e le emarginate che “sopravvivevano” alla Cabotina, un quartiere composto da misere abitazioni, vista precipizio, che si ergeva all’esterno delle mura del paese.
I due inquisitori non riuscirono a concludere il processo causa il repentino allargamento delle accuse a tutto il tessuto sociale.
Il dramma di Triora era solo all’inizio. Il governo di Genova intervenne personalmente nella questione. Il vescovo di Albenga, Mons. Luca Fieschi chiese spiegazioni al Del Pozzo sul suo operato attraverso una missiva. Tra i due iniziò un breve rapporto epistolare che non cambiò la sorte delle donne incarcerate ancora in attesa di giudizio.
Il Del Pozzo sosteneva la presenza del Maligno come elemento portante della sua difesa; contemporaneamente anche il Consiglio degli Anziani ritirò le proprie perplessità precedentemente espresse riaffermando il proprio appoggio all’operato degli inquisitori. Nel frattempo però il processo subì un rallentamento; nel gennaio del 1588 i due inquisitori partirono da Triora, lasciando dietro di sé una situazione drammatica. Da qui in poi è un susseguirsi di lettere al governo genovese e richieste di aiuto che cadono inascoltate.Il Parlamento locale, iniziale fautore del processo, mutò rapidamente opinione, incaricando il notaio triorese Basadonne di scrivere a Genova per chiedere una rapida revisione del processo. Si attese fino a maggio per ottenere la visita inconcludente del padre inquisitore Alberto Fragarolo che dopo qualche interrogatorio lasciò Triora senza risolvere la situazione, esattamente come i suoi predecessori.
Nel mese di giugno arrivò l’autentica svolta della vicenda, quella che nessuno però si sarebbe augurato. Il giorno 8 giunse a Triora, mandato da Genova, il commissario speciale Giulio Scribani, già Pretore a San Romolo, paese dell’entroterra di Sanremo. Un mese dopo, in una sua lettera a Genova, lo Scribani affermava in maniera inquietante di essere giunto a Triora “per smorbar di quella diabolica setta questo paese che resta quasi per tal conto tutto desolato”. Nel frattempo avvenne un avvicendamento di podestà; Stefano Carrega lasciò il posto a Gio Batta Lerice. Lo Scribani per prima cosa inviò nelle carceri genovesi tredici donne e il solo uomo che giacevano nelle prigioni trioresi al suo arrivo. Da qui in poi sarà un escalation di arresti e torture.
Nei mesi successivi lo Scribani imperversò in tutta la zona aprendo nuovi casi e facendo morire donne innocenti. Per l’ennesima volta si verificò un colpo di scena: di fronte alla richiesta del via libera per decine di condanne a morte, il Doge iniziò a nutrire i primi dubbi sull’operato del commissario. Perplessità che sfociarono in una richiesta allo Scribani di attenersi alle confessioni e soprattutto di provarne la veridicità con riscontri reali e plausibili. Il richiamo cadde nel vuoto.
Lo Scribani era ormai un cane sciolto. Genova affidò la revisione del processo all’uditore e consultore Serafino Petrozzi che sottolineò come lo Scribani si fosse interessato a reati connessi alla stregoneria, materia di esclusiva competenza dell’Inquisizione. Ma anche il Petrozzi concluse la sua relazione dicendo che la questione era troppo delicata e la possibilità di commettere errori elevata. In pratica se ne lavò le mani. Lo Scribani nel frattempo continuava a incarcerare donne e a difendersi dalla critiche con numerose lettere: a Triora e nei borghi confinanti come Andagna, Bajardo, Montalto Ligure si registrarono le morti di tante innocenti. Prima di vedere uno spiraglio si dovranno attendere mesi. Lo Scribani per il suo scellerato operato subì la scomunica da parte dell’Inquisizione stessa, rimessagli poi, per intervento del Doge, il 15 agosto 1589.
Il 28 aprile 1589 fu la Chiesa a dare un segnale di speranza concreto: i cardinale Sauli e quello di Santa Severina, fecero giungere l’ordine di chiudere i processi e per la prima volta, come si legge nella loro missiva, le streghe di Triora vennero chiamate “sudditi della Signoria” restituendo, almeno a parole, dignità alle innocenti. Nel frattempo altre due donne passarono a miglior vita; il 27 maggio toccò al Doge lamentarsi con il Cardinale Sauli del fatto che ancora non si fosse fatto niente. Solo il 28 agosto il Cardinale di Santa Caterina confermò la volontà dell’Inquisizione di chiudere i processi. E così la parola fine fu posta a sigillo dell’intera vicenda.
Che fine fecero le streghe di Triora? Morirono in carcere o furono liberate? Da qui in poi il loro triste destino sprofonda nell’oblio del tempo per la mancanza di documenti. Alcuni storici sostengono che le donne rinchiuse a Genova furono liberate: la prova sarebbe leggibile nei registri parrocchiali di San Martino di Struppa, paese della Val Bisagno, a quel tempo colonia penale di Genova. Dal 1600 in poi compare il cognome Bazoro e Bazura che richiama inequivocabilmente bagiua, termine con il quale sono chiamate le streghe a Triora. Su quelle incarcerate nel piccolo paese ligure si sa ben poco.
Al di là della drammaticità della vicenda le ipotesi più recenti sul processo hanno portato all’esame di alcune grandi anomalie che farebbero pensare che dietro all’accusa di stregoneria, il grande processo servì a nascondere situazioni al limite della legalità che vedevano il coinvolgimento delle stesse famiglie nobili di Triora. Un’oscura trama di rapporti politici, economici e interessi personali fa da sfondo ad una delle pagine più nere della nostra storia.”