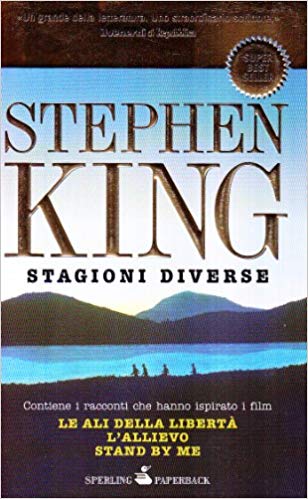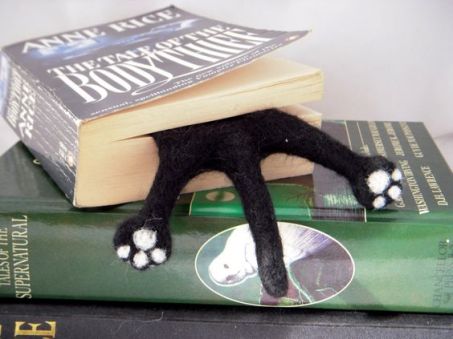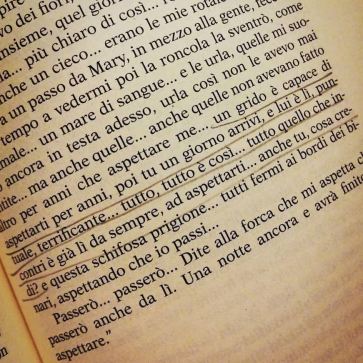Paula Hawkins è tornata. Il suo nuovo thriller è balzato in testa alle classifiche con l’agilità di un ghepardo, e noi lettori cosa ci dobbiamo aspettare? Quest’autrice da un milione di dollari è sbucata fuori dal nulla in un giorno qualunque di qualche anno fa e non è mai più scesa dall’olimpo delle vendite. Pensavo che sarebbe stato impossibile per la Hawkins bissare il successo precedente, anche perché per quanto “La ragazza del treno“ mi sia piaciuto parecchio , è ben lontano dall’essere un capolavoro di genere. Comunque sia io ho acquistato e letto “Dentro l’acqua”, certa che nella peggiore delle ipotesi mi avrebbe regalato qualche giornata di suspence e divertimento.
L’autrice, come è logico, ricalca i passi che l’hanno resa celebre confezionando un thriller psicologico angosciante, in cui dominano le sensazioni negative: la paura, i ricordi dolorosi, le verità taciute, i segreti inconffessabili. Ancora una volta il protagonista assoluto non è un individuo in carne ed ossa: come a suo tempo il treno fu l’elemento cardine su cui ruotò tutta la storia, un corpo mobile che traghettava le angosce quotidiane della protagonista, così in quest’ultimo thriller è il fiume della piccola cittadina di Beckford, nel nord dell’Inghilterra, a trascinare nell’oblio vite disgraziate. Un rituale ancora una volta dannato ed al tempo stesso liberatorio in cui l’acqua, simbolo per antonomasia di vita e prosperità, assume qui il significato opposto e diventa l’ultimo rifugio di donne disperate.
A Beckford, diversi secoli fa, c’erano le streghe. Le donne del paese che erano in grado di preparare intrugli curativi, oppure quelle dotate di una conturbante bellezza, venivano additate come concubine del demonio e per questo perseguitate ed imprigionate. Uomini pusillanimi e spaventati le torturavano senza pietà, sperando che questo bastasse a scacciare dai loro lombi istinti peccaminosi. Le streghe di Beckford venivano immerse nell’acqua del fiume che attraversava il paese, perché se i loro corpi galleggiavano anzichè andare a fondo come quelli dei comuni mortali significava che operavano tramite il maligno. Quella placida conca sovrastata da un alto promontorio diventava la loro tomba: lo Stagno delle Annegate.
Storie antiche, crudi racconti che il tempo ha ormai trasformato in leggenda. Solo il fiume è sopravvissuto, monito di punizione ed orrore, e quell’avallamento profondo in cui moltissime donne hanno perso la vita. Dalla piccola Libby, affogata dalla brava gente del paese nel 1679 perchè aveva sedotto un uomo molto più grande di lei, fino alla studentessa suicida Katie, sembra che il fiume chiami a sè tutte le donne infelici di Beckford per avvolgerle nella pace delle sue acque scure. L’ultimo anello di questa spirale di morte è Nel Abbott, che pare essersi suicidata anche lei tuffandosi nello Stagno delle Annegate. Sua sorella Jules, arrivata in paese in seguito al tragico ritrovamento del corpo di Nel, non crede però all’ipotesi del suicidio. Conosce sua sorella, e nonostante non si parlino da anni sa perfettamente che non avrebbe mai compiuto un gesto del genere. Nel fin da ragazzina era ossessionata dalle storie di quelle donne suicide, voleva capire cosa le avesse spinte ad ascoltare il richiamo del fiume di Beckfort, scegliendo l’ottenebramento: c’era qualcosa di ancestrale in quel luogo, qualcosa che le abbracciava in modo intimo, donando loro quel conforto che in vita non avevano mai ricevuto? Probabilmente sì. Nel sa che esiste un istante perfetto, poco prima dell’annegamento, in cui i disperati ritornano allo stadio primordiale, quando galleggiano nell’utero materno: un attimo eterno in cui desiderano soltanto lasciarsi andare, cullati da quelle acque morbide. Ma Nel sapeva anche un’altra cosa: sapeva che “Beckford non è un luogo di suicidi. Beckford è il luogo in cui liberarsi delle donne che portano guai.” Come le streghe, come Libby, come Lauren, Anna e Katie. Ed infine come lei stessa.
In paese tutti erano a conoscenza delle indagini che Nel stava compiendo a proposito delle donne suicide. Ha raccolto materiale, ha chiesto, ha ascoltato le storie di ogni famiglia coinvolta perchè voleva dare voce alle loro sofferenze, voleva capire. Era come ossessionata. Il libro che voleva scrivere però ora giace incompiuto nella sua camera da letto, destinato a restare inedito. La disperazione delle donne di Beckford ancora una volta resterà inascoltata, sepolta negli abissi de Lo Stagno delle Annegate.
“Alcuni dicono che quelle donne hanno lasciato qualcosa di sé nell’acqua, che il fiume ha trattenuto un po’ del loro potere, perché da allora le sue sponde attraggono le donne infelici, disperate, perdute. Vengono qui e nuotano con le loro sorelle.”
Jules è decisa a scoprire la verità su sua sorella, per riscattarsi dalle proprie colpe e per aiutare Lena, la figlia di Nel, un’adolescente difficile ed arrabbiata con il mondo con cui è impossibile comunicare. Dovrà scontrarsi con la riottosità di quel piccolo paesino di campagna, una sorta di Twin Peaks inglese che dietro alla sua facciata da cartolina nasconde orrorifici segreti, in cui ogni abitante protegge sè stesso da scomode verità. Anche a costo di compiere gesti estremi.
La narrazione non è fluida, anzi. Le voci che compongono questa storia sono molte, ognuna con la propria parte di verità da mostrare e quella da nascondere con cura. Spesso mi sono ritrovata in difficoltà, ingarbugliata in una matassa polifonica di nomi, situazioni, ricordi; pagina dopo pagina l’autrice compone una sinfonia di morte e di dolore, di sofferenza e solitudine che culmina nello spiazzante finale, quando tutti i frammenti convergeranno nella stessa direzione ed i narratori si riuniranno in un’unica voce: quella della verità.
Paula Hawkins è brava, ed in quest’ultimo thriller non fa che riconfermare un innato talento per la costruzione di storie contorte ed oniriche, proprio come la psiche umana quando traballa tra realtà e ricordi dolorosi. Ancora una volta siamo di fronte ad una narrazione dominata dall’elemento psicologico più che dalla trama in sè, in cui non esistono paladini delle giustizia, ma solo perdenti. Ed è questo a mio avviso l’elemento vincente che l’autrice sfrutta così bene: quella di dare voce agli sconfitti, agli anti eroi, a vite spezzate in cui non c’è più spazio per la redenzione.
Dentro l’acqua, Paula Hawkins (Piemme)