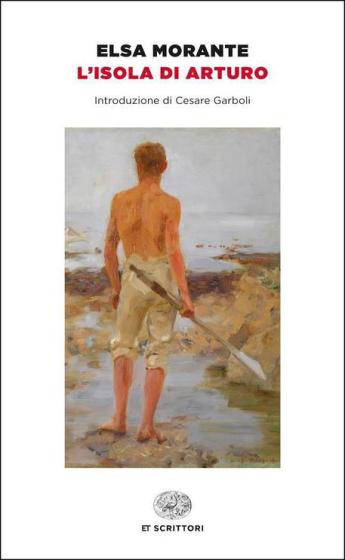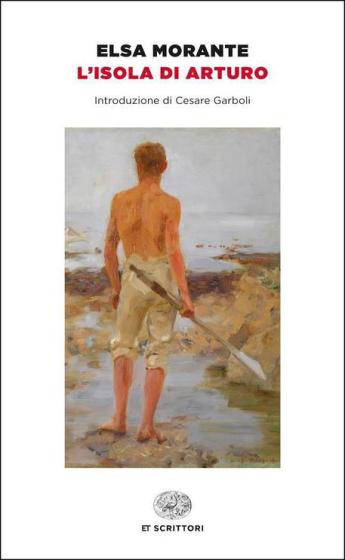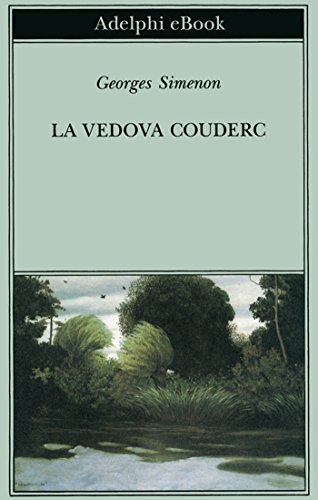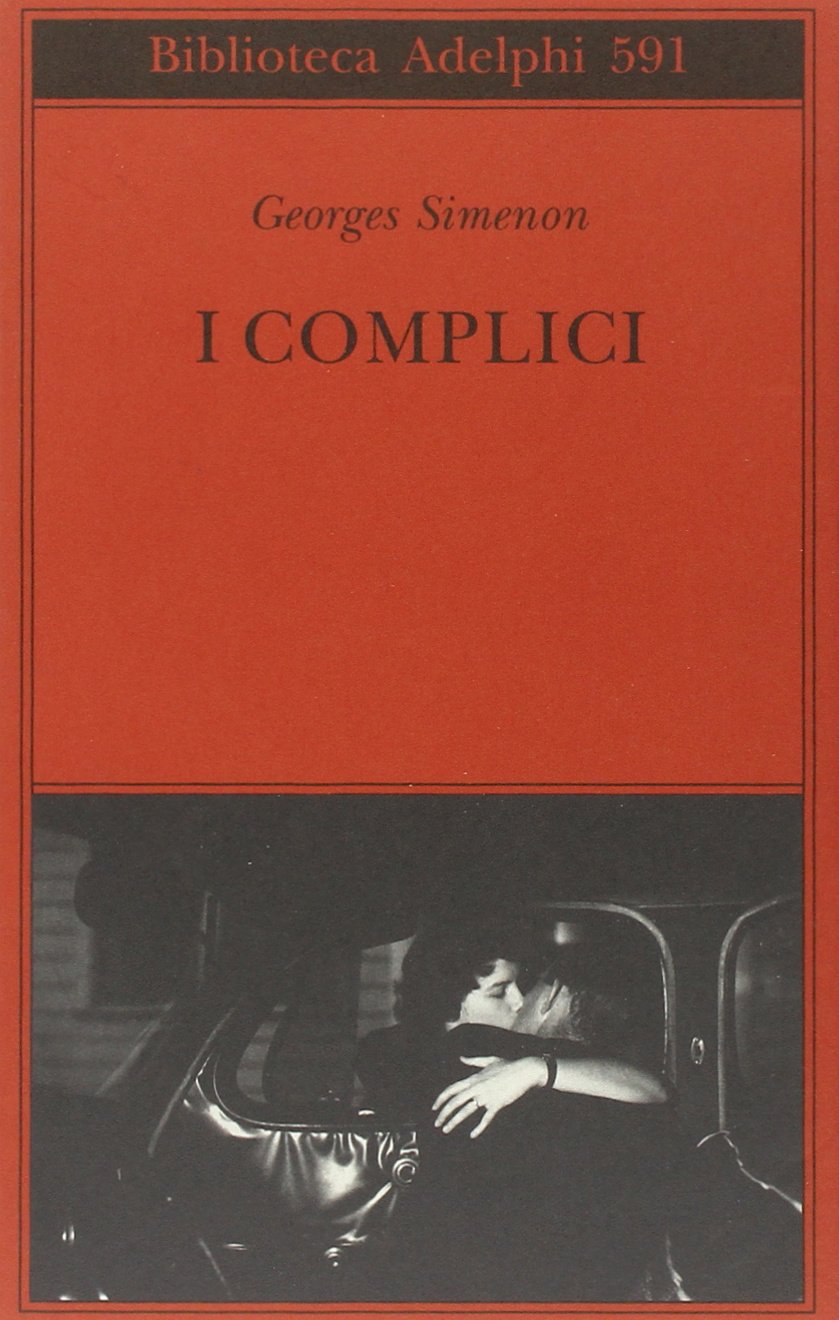L’anno scorso sono stata a Procida. E, forse, non sono più veramente tornata.
Il romanzo è ambientato tra il 1935 e il 1940, poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Arturo Gerace è un bambino che ha vissuto tutta la sua vita sull’isola di Procida, la quale rappresenta il suo intero universo, affettivo e geografico. Cresce allevato da un uomo che gli fa da balia, perché la madre muore dandolo alla luce ed il padre Whillelm è sempre lontano da Procida. Suo padre, così come il resto del mondo che conosce solo attraverso i libri, assumono per lui una dimensione leggendaria, che travalica la realtà per confodersi con la sua fantasia di bambino. Durante la bella stagione, che a Procida dura da aprile a settembre, passa il tempo a fare lunghi bagni, escursioni in mare con la sua barca, o a giocare in spiaggia con il suo cane Immacolatella. Quando l’autunno comincia ad abbracciare l’isola, anticipando ogni giorno l’ora del tramonto, Arturo si chiude nella “Casa dei Guaglioni” a leggere le storie dei Condottieri e a tracciare sull’atlante la linea immaginaria dei suoi viaggi. Quelli che, una volta cresciuto, avrebber intrapreso con il padre. Per lui Wilhelm è una specie di eroe, un marinaio avventuroso, un vero viaggiatore e cittadino del mondo: così giustifica in cuor suo le lunghe assenze del genitore, cercando nell’immaginazione quell’amore che non c’è mai stato, quell’assenza di carezze e di gesti d’affetto che per un bambino sono la vita stessa. La Morante non insiste mai sull’infanzia avara del bambino, ma anzi amplifica il sentimento di amore filiale di Arturo nei confronti di suo padre.
Le lunghe attese del ragazzo sulla spiaggia di Procida sono sempre descritte con emozione e gioia, perchè Arturo sepeva sempre in cuor suo quando il vaporetto sarebbe giunto da Napoli con il suo prezioso carico. Era per lui il giorno più bello, a cui sarebbero seguiti molti altri, fino alla nuova partenza di Wilhelm. Nonostante l’infanzia vissuta senza obblighi e senza regole, spensierata e giocosa, Arturo porta inevitabilmente dentro di sè un grande vuoto: la malinconia di un bambino che non sa dare un nome alla sua fame d’amore.
“Allora, i miei occhi e i miei pensieri lasciavano il cielo con dispetto, riandando a posarsi sul mare, il quale, appena io lo riguardavo, palpitava verso di me, come un innamorato. Là disteso, nero e pieno di lusinghe, esso mi ripeteva che anche lui, non meno dello stellato, era grande e fantastico, e possedeva territori che non si potevano contare, diversi uno dall’altro, come centomila pianeti! Presto, ormai, per me, incomincerebbe finalmente l’età desiderata in cui non sarei più un ragazzino, ma un uomo; e lui, il mare, simile a un compagno che finora aveva sempre giocato assieme a me e s’era fatto grande assieme a me, mi porterebbe via con lui a conoscere gli oceani, e tutte le altre terre, e tutta la vita!”
Gli incantesimi si sa, non durano per sempre. E anche l’incanto di Procida, che protegge l’infanzia di Arturo come una boccia di cristallo, si spezza un giorno come tanti. Un bagaglio nuovo di sentimenti contrastanti ed emozioni sconosciute fanno breccia nel cuore del ragazzo che, ancora una volta, non sa dare un nome a ciò che prova. Di ritorno da uno dei suoi viaggi, Wilhelm porta con sè a Procida una ragazza giovanissima, Nunziata, la sua nuova moglie. Arturo non ha mai conosciuto nessuna donna, nemmeno la propria madre, e all’inizio questo incontro lo disorienta. Il suo animo infantile la disprezza, ritenendola un essere inferiore, perché ha la convinzione che tutte le femmine, nessuna esclusa, siano brutte e stupide. Ma soprattutto, Nunziata non è degna di prendere il posto di sua madre. Arturo è geloso delle attenzioni che il padre riserva alla sposa, ma non comprende la vera natura sua rabbia; ed è così che alza un muro contro la ragazza, fatto di silenzi e di fughe. Durante le lunghe assenze di Wilhelm da Procida Arturo e Nunziata sono costretti ad una convivenza difficile, perché mentre Nunziata cerca di instaurare un rapporto con il ragazzo, ottemperando ai suoi doveri di matrigna, lui non le rivolge la parola e la evita, addirittura non la chiama mai nemmeno per nome. Arturo è incosnapevolmente attratto dalla giovane donna: il rancore, il rifiuto e il disprezzo che le riserva non sono altro che i confusi germogli di un sentimento che piano piano si fa spazio dentro di lui.
Da questo momento in avanti, gli avvenimenti si susseguono rapidi e la malìa di Procida sembra aver allentato momentaneamente la presa su Arturo. Non corre più spensierato per le vie del borgo e poi giù fino alla spiaggia, pensando alle storie dei grandi Condottieri; nemmeno si illude più di compiere viaggi da grande esploratore intorno al mondo. I suoi tormenti sono ora reali, non immaginari, e non deve cercarli lontano da Procida perché sono proprio lì, nella grande casa che abita da quando è nato. Arturo sta crescendo, sta diventando un uomo, sperimenta la gioia e il turbamento dell’amore e del sesso, che troverà in un’intraprendente amica di Nunzia. Anche gli altri protagonisti vivono profondi sconvolgimenti, sembra che nulla sia più uguale a prima, per nessuno. Nunziata subisce come una disgrazia i sentimenti che si accorge di provare nei confronti del figliastro, dilaniata dal senso di colpa e dal peccato. Riversa tutto il suo amore sul figlioletto Carmine, nato l’anno prima, ormai consapevole di non avere mai avuto nulla all’infuori di questo: nè Wilhelm, nè Arturo.
Wilhelm, tornato a Procida dopo un lunghissimo periodo di assenza, è ora sofferente e sfuggente, al punto che Arturo non lo riconosce più. Aspettava con ansia il suo ritorno perché era sicuro che il padre l’avrebbe portato con lui durante il suo prossimo viaggio. La soluzione al suo disagio stava tutta lì, nella concreta possibilità di partire, di scappare da Procida e da quello che ormai l’isola rappresentava. Abbandona anche la sua amante, per la quale non prova nulla, perché si sente rifiutato da tutti e disperatamente solo. La scoperta più amara di Arturo non sarà però l’amore non ricambiato per Nunziata, ma riguarderà l’eroe della sua fanciullezza: suo padre. Sarà la ferita definitiva, quella che non guarirà e che gli farà prendere una decisione sofferta ma inevitabile. Le pagine in cui la Morante ci guida nel labirinto di sentimenti che prova Arturo in questo frangente sono a mio avviso tra le più belle non solo di tutto il romanzo, ma che abbia mai letto in generale. La scrittura raggiunge livelli altissimi mentre l’isola di Procida sfuma nei suoi contorni, non può più essere solo un paesaggio, perchè si confonde e si completa con l’anima di Arturo; la delusione e la sofferenza del ragazzo non trovano pace, ma in quel disincanto c’è una poesia di rara bellezza. Riusciamo a percepire l’intensità del suo il dolore, ma al tempo stesso non possiamo sottrarci al fascino di Procida, che continua ad abitare il cuore del giovane anche quando è spezzato dagli eventi. Indimenticabili le ultime righe, quando Arturo dice addio a suo modo all’isola, abitata dall’amore e dall’odio nella stessa misura, ma pur sempre parte di sè. L‘isola è il simbolo della fanciullezza spensierata e dolce, in cui l’innocenza sembra eterna e la realtà è solo un’eco lontana che non ci sfiora mai. Quando la vita inevitabilmente irrompe con le sue dure leggi anche Procida assume un aspetto diverso, diventa desiderio di fuga, dispiacere, dolore. L’età adulta ci porta in dono la consapevolezza e la capacità di distinguere la realtà dalla fantasia, e rivela le menzogne che spesso ci costruiamo da soli, in un gioco infantile. Quasi sempre però è un boccone amaro, per Arturo come per chiunque di noi.
“…Come fui sul sedile accanto a Silvestro, nascosi il volto sul braccio, contro lo schienale. E dissi a Silvestro: – Senti. Non mi va di vedere Procida mentre s’allontana, e si confonde, diventa come una cosa grigia…Preferisco fingere che non sia esistita. Perciò, fino al momento che non se ne vede più niente, sarà meglio ch’io non guardi là. Tu avvisami, a quel momento.
E rimasi col viso sul braccio, quasi un malore senza nessun pensiero, finché Silvestro mi scosse con delicatezza, e mi disse: – Arturo, su, puoi svegliarti.
Intorno alla nostra nave, la marina era tutta uniforme, sconfinata come un oceano. L’isola non si vedeva più.”
L’isola di Arturo – Elsa Morante (Einaudi)