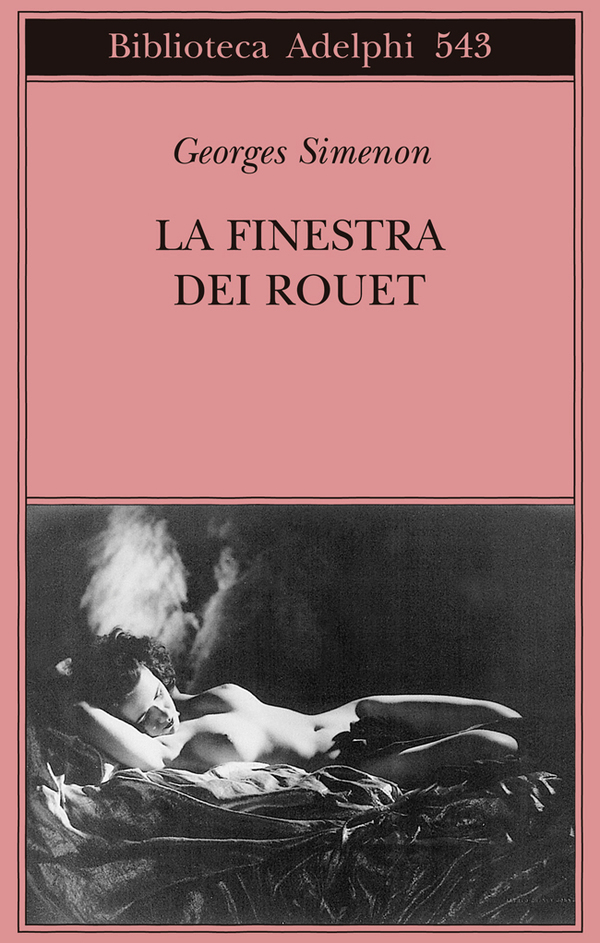Un paio di mesi fa ho partecipato alla presentazione del nuovo libro di Cinzia Leone, “Ti rubo la vita”, edito da Mondadori all’inizio di quest’anno. L’ autrice prima di iniziare a parlare del suo romanzo ha voluto conoscere il nostro gruppo di lettura, che si sarebbe concluso di lì a poco, e mi ha molto colpita Il suo modo di fare semplice e spontaneo, così cordiale. Durante la presentazione questa mia impressione positiva non ha fatto che aumentare per la grande professionalità e per la notevole cultura che ha dimostrato di possedere. Sono tornata a casa tardissimo, con il suo romanzo autografato sotto braccio, entusiasta dell’esperienza e desiderosa di tuffarmi subito nella lettura. E’ difficile inquadrare “Ti rubo la vita” in un genere specifico, perchè “romanzo storico” non è una definizione esaustiva. E’ al contempo un romanzo al femminile, una saga familiare, un viaggio attraverso le tre grandi religioni monoteiste: islamismo, ebraismo, cattolicesimo. La narrazione è suddivisa in tre parti, ognuna delle quali racconta la storia di una donna diversa: Miriam, Giuditta ed Esther. Le loro storie si aprono e si chiudono come fossero libri a sè stanti, poichè ognuna di loro si muove all’interno di un differente contesto storico e religioso, ma in realtà un filo invisibile lega tra loro le vite delle protagoniste: l’ultimo nodo, il più importante, lo scioglieremo solo nelle ultime pagine.

La prima parte è dedicata a Miriam, una donna musulmana che vive con la sua famiglia nella città di Jaffa dei primi anni 30. Suo marito Ibrahim è un mercante turco sull’orlo del fallimento, in cerca dell’occasione giusta per riscattarsi da una vita di espedienti. Nel XIX secolo Jaffa era uno dei centri economici e culturali più importanti della Palestina, oggi inglobata dalla moderna Tel Aviv: un crocevia di commercianti, di popoli, di culture differenti. Il suo vicino di casa è Avrhàm Azolulay, un ebreo benestante che sta per concludere un importante affare con una partita di pregiato cotone. Una notte, durante un polgrom in Palestina, Avrahm, sua moglie Miriam e la figlioletta Hava vengono brutalmente massacrati: un incipit straordinario ci inchioda fin da subito alle pagine. Ibrahim sente le urla disperate della famiglia ma non interviene; spinto da un’idea scellerata e morbosa, in quella notte terribile deciderà di rubare l’identità di Avrhàm per sostituirsi a lui negli affari, incassando così la parte di contratto al posto del defunto ebreo. Per Ibrahim si tratta di una scelta necessaria al suo riscatto sociale, scelta che impone anche alla moglie: lei dovrà essere la nuova Miriam, e sua figlia Jasmin sarà Havah. Completamente ottenebrato dai suoi sogni di gloria e ricchezza resterà impassibile di fronte alla disperazione della moglie, che non vuole e non può rinunciare a sè stessa e alla sua identità. Per dovere di obbedienza al marito deve disfarsi delle sue origini di contadina dell’Anatolia, dimenticarsi il culto islamico ed imparare tutto sulle tradizioni ebraiche: un asservimento per lei inaccettabile, amorale, malato. Più il marito si trasforma fino a confodersi in Avrhàm, più lei si allontanta inorridita, ergendo barricate fatte di silenzi e di rifiuti. L’assenza di parole e di contatto fisico si trasformeranno nella più potente delle armi, l’unica che riuscirà nel tempo a scalfire il cuore di Ibrahim, perseguitandone la coscienza fino alla fine dei suoi giorni.
Il cuore di Miriam era ormai sordo. Le raccomandazioni del marito non la sfioravano e la sofferenza della figlia la raggiungeva come un’eco lontana. La stava perdendo o l’aveva già perduta?
La seconda parte è dedicata a Giuditta. Giuditta è una ragazza ebrea di vent’anni che vive ad Ancona con il fratello Tobia e la madre gravemente malata. Il padre è lontano, a scontare la prigione come dissidente politico: è il 1943 e Davide Cohen, oltre ad essere ebreo, è anche un anarchico. Giuditta è ebrea suo malgrado, poichè non ha mai considerato la propria religione come qualcosa che la identificasse in modo così totalizzante: lo scoprirà solo in seguito alla promulgazione delle leggi razziali, a causa delle quali viene espulsa da scuola e dalla piscina comunale in cui amava nuotare. I fascisti le cuciono addosso la stella di David rendendola parte di una massa indistinta di esseri umani, colpevoli di appartenere ad una discendenza sbagliata. Iniziano così anni di fughe, di nascondigli improvvisati, di false identità e di paura; nonostante tutto però Giuditta resiste, si innamora, e si aggrappa disperatamente alla vita che le resta. Le ore, i giorni passati a fuggire dai rastrellamenti diventano uno spazio da riempire con le immagini di Giovanni, della sua famiglia, e di quell’acqua profonda che amava scalfire con bracciate lente e vigorose, ora più che mai simbolo di forza e di vita: quella che la guerra le aveva rubato senza pietà. La storia raccontata attraverso Giuditta è sicuramente quella più toccante e coinvolgente emotivamente, perché riguarda un tempo ancora recente che appartiene alla nostra memoria. Le pagine in cui viene rievocato il rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, il 16 ottobre del 1943, hanno la forza dirompente di un passato che pretende di essere raccontato ancora, affinchè nessuno possa dimenticare.
“Per salvarsi, Giuditta decise di fermare il tempo. E il tempo le obbedì: si restrinse fino a ridursi ai soli istanti che lei rubò a uno a uno. Ferocemente”
Infine c’è la storia di Esther, una storia contemporanea che ci porta dritte negli anni 90. Esther è una trentenne in crisi, con alle spalle una lunga serie di disastri amorosi ed un matrimonio sbagliato; non ha figli, ma forse non li ha mai desiderati veramente. Rispecchia alla perfezione il prototipo della donna moderna, affermata nel proprio lavoro ma sentimentalmente insicura, incapace di trovare serenità e stabilità nel rapporto di coppia. E’ figlia di un’epoca in cui tutto, anche l’amore, si consuma velocemente, attraverso un sesso ingordo e subito sazio, in cui pare essersi disperso il significato più intimo dell’unione. Esther sarà l’oggetto di una proposta anacronistica e affascinante: Ruben, quarantenne sfuggente e taciturno, con alle spalle una storia assai particolare, desidera sposare Esther perché sulla carta è perfetta per realizzare il suo obiettivo. Senza averla mai conosciuta prima le propone un contratto matrimoniale e una sporadica frequentazione pre-nozze priva di contatto fisico. Come mai, in pieni anni 90, nell’epoca dei rapporti mordi e fuggi e del sesso senza complicazioni Ruben propone proprio a Esther un matrimonio combinato? Ma, soprattutto, chi è Ruben e perché vuole proprio lei? Esther è probabilmente la protagonista con cui è più facile immedesimarsi, perchè con le sue fragilità ed i suoi dubbi, le sue paure ed il suo dolore di figlia è lo specchio del nostro mondo interiore, in cui spesso dimora il caos. Ma proprio Esther ci insegnerà che la vita stupisce continuamente, e che spesso è proprio ciò che giudicavamo improbabile a salvarci da noi stesse.
…Impara ad accettare le sfocature della vita. Solo in quei contorni sfumati troverai la verità.
Queste sono le tre donne che incontreremo leggendo, tre donne molto diverse tra loro, ognuna delle quali rappresenta una diversa sfaccettatura dell’animo femminile: Miriam è la forza che si ribella alla sottomissione, Giuditta la resilienza che si oppone alla crudeltà della vita, ed Esther la speranza che vince sull’incertezza del futuro. Ciò che accomuna le tre parti di questo romanzo, oltre all’appassionante intreccio familiare, è il concetto di identità: questa parola, così ricca di significato, è il perno su cui ruotano tutte le storie narrate. Identità rubate, come quella di Miriam; identità cucite addosso, come la stella di David di Giuditta, che le imprime un marchio a fuoco da cui non si libererà mai più; identità ricercate con ostinazione, come quella di Esther, ebrea da parte di madre ma cattolica grazie al battesimo. La storia di ogni singolo protagonista fa profondamente riflettere sul significato delle nostre origini, della nostra memoria, sul senso di appartenenza.
E’ inevitabile porsi domande sul significato di identità: fino a che punto siamo quello che scegliamo liberamente di essere ? Quando invece è la nostra storia familiare a decidere per noi? Le azioni compiute dai protagonisti influenzano inesorabilmente il destino altrui e quello dei propri figli, a dimostrazione del fatto che tutti noi siamo quello che siamo per una mera casualità del destino, per scelte che non abbiamo compiuto. Se la vita si può rubare, come se fosse un oggetto qualsiasi, cosa resta di noi stessi? Cosa definisce la nostra persona, quali sono i confini invalicabili?
La scrittura di Cinzia Leone ha una forza espressiva che rara. La sua penna è un fiume in piena in grado di amalgamare l’energia e la passione con la delicatezza e l’intensità del linguaggio poetico, rendendo alcuni passaggi toccanti e memorabili. Ma scrivere bene non è sufficiente. La costruzione di un romanzo storico è un processo complesso, che mette in gioco tante abilità: bisogna conoscere profondamente ciò di cui si vuole scrivere, perchè ogni dettaglio, anche il più insignificante, deve incastrarsi perfettamente con il meccanismo principale, rendendo il racconto lineare, privo di sbavature. Anche per questo l’autrice merita un grande plauso, perché si può ben intuire quanto studio ci sia stato dietro la stesura di un romanzo di questa portata. E’ riuscita a destreggiarsi abilmente tra le pieghe della storia rievocando non solo episodi noti, ma anche tradizioni religiose antiche, sconosciute alla maggior parte di noi cattolici occidentali, con straordinaria padronanza. Ogni frase, ogni parola, ogni virgola fanno parte di una costruzione minuziosa e ricercata, eppure il risultato è una narrazione sorprendentemente fluida, che avvinghia alle pagine e ci trasporta letteralmente in un’altra dimensione, come i migliori romanzi sanno fare. E questo senza dubbio lo è.

Cinzia Leone mi ha lasciato una dedica sul libro, il giorno della presentazione: “Tre donne che amerai”. Ed è vero. A distanza di mesi non ho ancora diementicato nè Miriam, nè Giuditta, nè Esther: credo che mi faranno compagnia ancora per un bel pò.